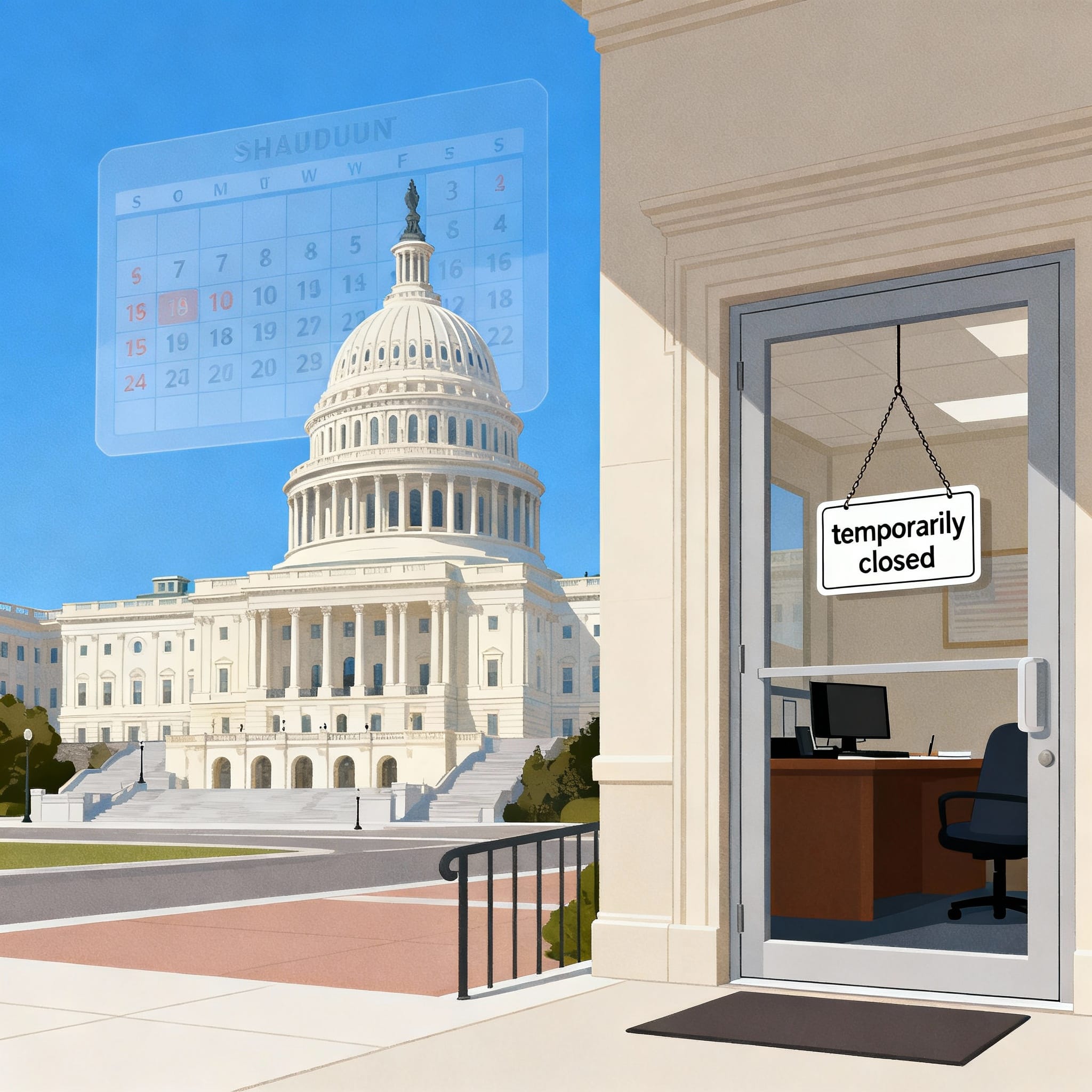Il weekend si avvicina e negli Stati Uniti aleggia la consueta minaccia dello shutdown federale: il Congresso non ha ancora partorito un accordo sul budget, e il giorno del giudizio fiscale – cioè la scadenza del 30 settembre, fine dell’anno fiscale – incombe puntuale come la pioggia nel weekend.
I titoli dei giornali preconizzano servizi pubblici fermati, dipendenti federali costretti a improvvisarsi creativi nella gestione delle finanze, e parchi nazionali che potrebbero finalmente prendersi una meritata pausa dal turismo di coppie di italiani in viaggio di nozze.
In realtà, la storia è più vecchia di me. Il balletto sul budget si consuma pressoché ogni anno e la disputa è sempre la stessa: le infinite fazioni del Congresso bloccano il meccanismo statale in nome di interessi opposti e visioni paradossali della funzione pubblica.
La pratica dello shutdown si è affermata a partire dal 1976, quando il moderno processo di bilancio fu introdotto. Da allora, il paese ha vissuto ben venti episodi di blocco amministrativo, con pochi veri shutdown storicamente significativi.
I più lunghi e dolorosi sono recenti: nel 1995-96 lo scontro tra Bill Clinton e il Congresso repubblicano portò a uno stop di 21 giorni, battuto dal blocco di 35 giorni tra dicembre 2018 e gennaio 2019, nato attorno a una disputa tra la Casa Bianca di Trump e una Camera dominata dai democratici sul finanziamento del muro con il Messico. Nel 2013, il Congresso si fermò per 16 giorni sulle coperture dell’Affordable Care Act (Obamacare). In media, lo shutdown è frutto di divisioni politiche cristallizzate, dove la legislatura esercita il proprio potere di bilancio come arma negoziale, mentre il Presidente può solo frapporre il veto e attendere che Camera e Senato trovino un compromesso.
Gli attori principali, questa volta, si azzuffano su sicurezza dei confini, spese per la difesa e altre sacre vacche della politica americana. Il presidente Trump, le cui inclinazioni per la suspense sembrano perfettamente allineate con i cliffhanger degni di una telenovela argentina, non fa mistero del fatto che un eventuale shutdown potrebbe rivelarsi “giusto”: una potatura necessaria contro i rami secchi del bilancio.
Il rischio di chiusura non è solo uno spettacolo per la stampa, ma la manifestazione più limpida di quanto sia fragile il patto sociale statunitense sullo Stato. Per gli appassionati di mercati liberi e Stato minimo – quelli che vedono nella chiusura del governo un esperimento pratico di privatizzazione forzata – lo shutdown ha un singolare fascino didattico. È la caricatura della tesi anarco-capitalista: meno Stato, meno problemi. Le agenzie pubbliche restano ferme, i servizi si rimpiccioliscono fino a diventare asintotici, la popolazione riscopre l’incertezza delle regole e i mercati fanno stretching in attesa che qualcuno riaccenda la luce.
Ma il vero dramma non è la sospensione dei servizi, bensì l’assenza di una narrazione chiara: che senso ha uno Stato che ogni anno va incontro al rischio di spegnersi per mancanza di fondi? L’ironia è che il governo statunitense – motore della più grande economia del mondo – deve mendicare consenso dai suoi stessi rappresentanti, come un impiegato che chiede anticipo sulle ferie. Sotto questa patina tragicomica, la realtà riemerge: lo shutdown non è altro che una serie TV, rinnovata ogni stagione, che pochi pagherebbero su Netflix se non fosse che i protagonisti sono dotati di atomiche e di poteri regolatori su Wall Street.
Forse anche qui, come nel complesso militare US, servirebbe una IA per gestire le finanze pubbliche con logica ferrea e zero isterismi. Altrimenti, ai mercati e ai cittadini non resta che trattenere il fiato, godersi lo spettacolo e ricordare che, almeno per qualche giorno, il sogno di uno Stato che non disturba nessuno smette di essere solo un sogno.